C’è una tensione verso il fantastico nella scrittura di Veronica Galletta, il tentativo di sovrapporre alla realtà una rete altra per comprenderne le regole: dalle mappe delle Isole di Norman (Italo Svevo, 2020) al fantasma di Nina sull’argine (minimum fax, 2022; già recensito sulla nostra rivista). Anche in Pelleossa (minimum fax, 2023) la narrazione fa spazio alle sculture parlanti del giardino di Filippu, l’artista ai margini della comunità di Santafarra dove è ambientata la vicenda, allo sguardo lunare del giovane protagonista e ai tanti animali, piante e luoghi carichi di valenze simboliche.
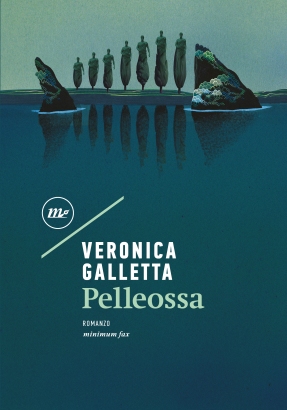
Sono gli occhi di Paolino, non a caso soprannominato Ncantesimo, a trasfigurare il tempo storico, la Sicilia dello sbarco americano e dell’immediato dopoguerra, in una dimensione sospesa tra fiaba e narrazione epica. Come un cavaliere nella sua personalissima quête, il bambino, contraddistinto da un marchio di estraneità che lo accompagnerà sino al termine della vicenda, attraversa i conflitti in atto nel suo paese – quello fra Terragni e chiddi di Sali, fra la comitiva dei ragazzi della Cava e tutti gli altri, fra comunisti e proprietari terrieri nelle lotte per la distribuzione agraria – alla ricerca della verità. Una verità ricostruita grazie alle voci degli esclusi, il cui punto di vista guiderà il percorso di formazione del ragazzo.
Eccolo perciò, una volta varcata la soglia del giardino proibito, diventare amico di Filippu, definito scultore di umanità – al tempo stesso estraneo al mondo (“«Fate anche ritratti», chiese Calogero. «Di gente viva? Mai! L’umanità viva è solo ossessione»”, p. 242) ma conoscitore della sua identità più vera («Chiffài?», si decise a chiedere [Paolino]. «Scolpisco la felicità», rispose Filippu”, p. 281). Proprio lì, in compagnia dei suoi cani e della fedele lucertola, Paolino scopre sé stesso dialogando con le sculture, leggendo il giornale all’amico analfabeta e apprendendo da lui il lato oscuro del sogno americano, dei legami fraterni e del percorso faticoso attraverso cui ogni uomo conquista la propria libertà.
E sono tanti, i maestri marginali del ragazzo: il nonno cestaio, grazie a cui raccogliere frammenti della storia familiare e comprendere la differenza fra padroni e cafoni (“«Quelle che c’arristavano [le cipolle] le vendevamo. Perché il Marchese se ne teneva la metà». «E perché?» «La terra era la sua». «Ma senza fare nenti. È assai». «Si chiamano patruni»”, p. 214). Zu Ntoni, il sordocieco che ridisegna la mappa della comunità attraverso gli odori dei paesani e indirizza il ragazzo verso quelli di cui fidarsi (“L’unica cosa che mi ha dato la solfata, levandomi tutto, è la nasca. Sento cose che l’autri non sentono. Come l’odore della paura. L’avevi tu, quando io ti pigghiai per la mano, l’avi Cateno quando sa frati lo picchia, l’aveva suo padre Nunzio dentro alla miniera. L’avemu tutti, ma devi stare attento. È come lo scuru nella miniera. Non ti specchiare troppo nella paura»”, p. 55). E ancora, i rappresentanti del mondo nuovo figlio della Resistenza e delle lotte sociali, quell’anima dissidente della comunità incarnata dal sindacalista Angelo Foglia, padre della sua amata Natalia.
La ricerca lo obbliga a svariate prove, come ogni epica che si rispetti. Le profondità naturali di cui è ricca la geografia di Santafarra sono lo scenario per eccellenza, il luogo dove affrontare la paura e riemergere cambiati: dal mare pieno “di pisci e scheletri”(p. 130), con tutte le sue risonanze attuali, dove suo padre e il fratello Pascali lavorano ogni notte; alla solfara, che minaccia i personaggi della comunità fino ad inghiottirne qualcuno; alla grotta di Filippu dove strepitano i conflitti della sua vita, come quello con l’odiato fratello Melo; fino allo sguardo del padre carico di rancore (“Gli pareva che dentro quel nìvoro suo padre se lo poteva risucchiare”, p. 309).
Ed è tutto il panorama siciliano a cantare. Un giardino a cielo aperto fitto di elementi evocativi – l’ulivo saracino sotto cui Paolino si rifugia, gli animali sapienti, la casa Verde come cardine delle vicende familiari. Tante le descrizioni in cui risuona la potenza dell’immaginario su cui è costruito il romanzo (“Dall’alto la Cava pareva un castello di sabbia, con gli spigoli mangiati dallo scirocco, e le balate che sudavano acqua, come sorgenti mute”, p. 102; “Dopo mesi accussì caldi che i pisci finevano nelle reti già cotti, era arrivato l’autunno di vento di terra, e dal Monte Cronio spiravano l’odori del bosco. Muschio, funghi, terra spostata dalle bestie che cominciavano a cercare riparo per il letargo”, p. 278).
Oltre a Paolino, tuttavia, la vera protagonista di Pelleossa è la lingua, il vero Ncantesimo che possiede le pagine. La creazione letteraria di Galletta, erede dei siciliani letterari della tradizione, da Verga a Vincenzo Rabito, sostiene la malia della storia, rende nitidi i personaggi e il brulicare della loro comunità. Ma non è un filtro pittoresco. La lingua diventa mappa del reale: il viaggio del protagonista è proprio una conquista di parole nuove per comprendere il mondo e agirvi. Il bambino scopre cosa significhi nabile, rimpatriato, pazzo in relazione a Filippu («Nu scemu». «Ed è scemu Filippu?» «Nzù. Solo tanticchia originale» gli dirà nonno Silvestro, p. 272), cosa significhi disertore riguardo a suo fratello Calogero (“«È un uomo che scappa per non fare una cosa». «È un uomo senza parola», aveva detto Paolino. «In un certo senso», aveva risposto Calogero, «ma è giusto essere senza parola quando le parole sono storte»”, p. 208), cosa siano l’America e gli americani, i patruni della terra e lo stesso nomignolo Pelleossa in cui risiede l’origine della sua identità.
Il risultato è un libro dalla lingua rigogliosa, riflesso di una Sicilia in movimento, agli antipodi del diorama gattopardiano (“nulla è sempre u stissu, anche quando pare”, p. 79) grazie agli occhi di Paolino e alla sua epica degli esclusi, cui il testo ridà voce con una carica costante di umanità e tensione morale.
Agostino Bimbo
