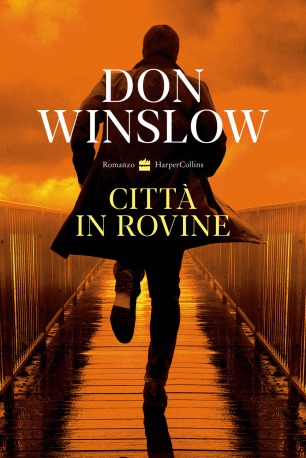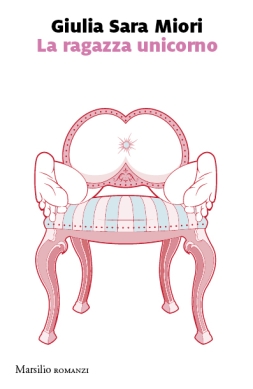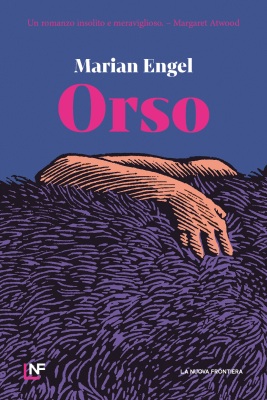C’è una vitalità malinconica nei personaggi della raccolta
Una florida ed eccitante vita interiore, dello scrittore australiano
Paul Dalla Rosa (Pidgin, 2024; traduzione di Stefano Pirone).
Quasi tutti giovani, smaniano ne

lle metropoli del mondo occidentale, da Dubai a Los Angeles, Tel Aviv e Melbourne, alla ricerca di successo e carriera. Il protagonista di
La fama, ad esempio, è un cantante ventenne che bazzica i palcoscenici della
Gold Coast australiana, surrogato dello star system californiano. Le sue giornate si consumano davanti a serie tv dedicate a personaggi celebri, in cui cerca (invano) una sorta di traccia per edificare la propria identità. L’unica occasione che gli viene offerta, dall’esito drammatico, non cambierà la sua situazione. Stessa parabola per il protagonista di
Storia di un master in fine arts, che brucia le sue velleità letterarie in giri criminali che ne sgretolano l’esistenza.
Non sono inerti, eppure ogni loro sforzo rimbalza contro una realtà indifferente. Lavorano quasi tutti ma hanno sempre bisogno di soldi. Le loro carte di credito American Express, spesso in rosso, sono semplici linee di credito che non garantiscono stabilità. Tutte le loro energie sono tese a racimolare denaro, pensiero fisso in quasi tutti i racconti (“Più tardi, inviai un lungo messaggio al mio ragazzo descrivendo l’intera vicenda […] Poi, una serie di tre emoji di contanti”, p. 31; “Di tanto in tanto nella mente di Sam si affollavano pensieri che correvano così velocemente da lasciare scie fantasma. I pensieri erano: SOLDI, Soldi, soldi e CONTANTI, Contanti, contanti”, p. 57).
Neanche le relazioni li appagano. Hanno amori virtuali o a distanza (“Lo dissi al mio ragazzo […] Era in Islanda alla scoperta di se stesso. […] Viaggiava sempre da solo”, p. 21; “Vivevamo in appartamenti separati”, p. 26). Ad avvicinarli al prossimo è l’uso di droghe o i regali che spediscono ai loro contatti online. Provano odio o gratitudine verso persone che non hanno mai conosciuto, come il protagonista di Comme, che freme per incontrare la responsabile della catena di negozi di abbigliamento in cui è impiegato (Ci riuscirà la sua collega: “Chiesi a Heidi se avesse parlato con R e cosa avesse detto lei. Heidi rifletté per un po’. Tenne le labbra unite, poi le aprì. «Grazie. Ha detto Grazie»”, p. 38)
La meccanica del fallimento è pressocché identica in tutte le storie. Non si tratta di agonismo sociale, legge del più forte in un mondo privo di valori. Il conflitto fra personaggio e realtà è assente perché quest’ultima è dominata da entità sovraumane, e come tali inaffrontabili: si pensi al gatto demoniaco che condiziona l’esistenza della protagonista di Charlie ad alta definizione, alle assicurazioni sanitarie che stritolano il povero Sam, protagonista di Mucchietto, ai padroni di casa e ai datori di lavoro mai visti. È un vuoto di potere quello che sovrasta la realtà narrata, o meglio una sproporzione tale fra il singolo e il suo destino da impedire qualsiasi epica (“Non sapevo se l’attività fosse tutta della donna – se fosse lei la proprietaria o sa se lavorasse per qualcun altro. In un certo senso tutti lavorano per qualcun altro e, quando non è così, lavorano all’interno di qualcos’altro, qualcosa di più grande. Sistemi, pensai. È tutta una questione di sistemi. È l’economia”, p. 146).
I personaggi, in un evidente circolo egocentrico, si limitano a contemplare sé stessi nella rete (“Io non facevo nulla durante il giorno. Non mi esercitavo o mi preparavo. […] Dopo una mattinata di E! camminai per casa scattando foto a me stesso. […] A volte le pubblicavo su Instagram e sulle app di incontri, non perché fossi in cerca di sesso ma perché mi piaceva ricevere complimenti” p. 96; o ancora “Si fotografarono a vicenda sul ponte. Lo yacht era fermo, attraccato al porto. Ciò non era evidente nelle foto”, p. 189). In alternativa, con una soluzione ancor più narcisista, tentano di vedersi vivere, costruiscono cioè piccoli mondi in cui muovere il proprio avatar. Una soluzione narrativa originale, ripresa in più brani, che descrive efficacemente la tragicità delle loro esistenze (“Emma aveva iniziato a vedersi come un modello in uno dei suoi rendering, o meglio come un avatar di Emma nel gioco The Sims o nella sua estensione Brooklyn. L’avatar di Emma era un Sim che giocava a The Sims per guadagnare denario, che però era sempre e solo sufficiente per continuare a giocare e, in certi momenti, per migliorare gli articoli per la casa”, p. 86; oppure “Sam pensò che sarebbe stato divertente se in questo ultimo Grand Theft Auto, avesse potuto lavorare in un Pancake Saloon. Poteva tornare a casa dal lavoro, aprire il suo file di salvataggio e far lavorare il suo personaggio al Pancake Saloon, entrando da un ingresso per i dipendenti renderizzato in 3D, con un’uniforme identica alla propria, e poi tornare alla sua tana, che sarebbe stata piena di tutte le cose belle che Sam avrebbe comprato”, p. 53).
L’ulteriore tentativo, infine, è quello di improvvisare una fuga dal mondo seguendo derive spiritualistiche. L’esito è grottesco. Esempio massimo è il racconto Life coach, in cui il protagonista si avventura in un viaggio in Oriente insieme ad altri influencer alla ricerca di esperienze edificanti. Il loro è un esercizio solipsistico, tautologico (“Era una persona molto spirituale e lo comunicava nella sua pagina «Chi sono» dicendo: «Sono una persona molto spirituale», p. 163”) mediato dai rispettivi profili virtuali in cui si vendono a vicenda fantomatici training esistenziali (“Le dissi che volevo fare un’esperienza spirituale e lei annuì, mi guardò negli occhi e rispose: «Ci sono dei video su YouTube per questo genere di cose»”, p. 175). Il tutto, guarda caso, si rivela una truffa (“Mi sentii meglio dopo aver mangiato i noodles. […] La canadese e il tedesco stavano parlando di Dio, del fatto che se Dio era tutto, allora il tavolo era forse Dio, e se il tavolo era Dio, ciò avrebbe cambiato il loro modo di interagire con esso? […] Poi andai di sopra La roba di Jacob era sparita e il mio bagaglio era sparito”, p. 177).
Ha il sapore amaro di una beffa, il percorso della raccolta di Dalla Rosa. Lo stesso atto di narrare, forse, sembra assoggettato alla logica inconcludente che grava sulle vicende dei personaggi. Le parole finali del protagonista de La fama sembrano esserne il manifesto: coinvolto contro la sua volontà in un videotape hard, dirà seccamente “Quella mattina feci l’unica cosa che sapevo fare; mi voltai verso la telecamera e diedi spettacolo” (p. 111).
Agostino Bimbo