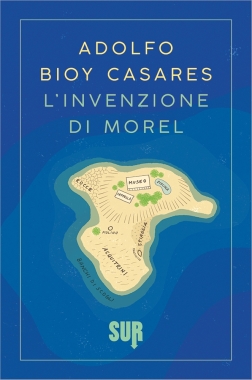Freddo. Nuvole troppo vicine al naso. Un lampo in fondo agli occhi quando finisce nel cono di luce di un lampione. Rotolare di sassi di un motorino che passa sghignazzando. Eugenio si stringe nel cappotto. Zaffata di naftalina. Preso dal mucchio, sì quello che ha portato don Mauro. Colori troppo rumorosi. Ma questo è nero. Nero va bene. E ora nella tasca un peso che prima non c’era. Strano. Buono. Fresco. Ci lascia scorrere sopra le dita. Continua a camminare.
Nel naso aveva odore d’incenso. Cantavano Santo, Santo, Santo. Quella la sa anche lui. Don Mauro gli dice sempre che ha una buona memoria. Li porta in chiesa tutte le domeniche, tutti insieme in fila indiana lungo i marciapiedi, seduti in fondo sull’autobus. Don Mauro li porta nella chiesa principale, però. Quella con quell’uomo sulla croce grande che ha sempre la faccia disperata, come Lorenzo quando si sveglia di notte nel letto accanto al suo, la bocca deformata, l’ultimo urlo infilzato nel labbro come gli ami di Barabba, che con lui non doveva parlarci diceva lei. Don Mauro li fa sedere nei primi banchi. Eugenio tiene le mani sotto le cosce. Ferme mani. Non bisogna spaginare il breviario, né tamburellare sul legno e nemmeno giocare a morra. Sotto le cosce. Così è giusto. Così va bene. Nella chiesa grande, però, ci sono candele e monete nel cestino con il manico lungo e fiori, fiori dappertutto e prude il naso e i fiori. Nella stanza che sa d’incenso, invece, non c’erano candele né fiori. C’era odore di legno vecchio e una lu ce piccola. E sul muro tante facce e divise e bianco e grigio. Piloti davanti ai loro aerei, piloti in posa, piloti contro lo sfondo del cielo e della pista vuota. Piloti come nonno Enrico, che non aveva mai conosciuto ma che sapeva come il Santo, Santo, Santo. Vorrei portarvi via tutti, aveva pensato. Ma poi si era guardato le mani ed erano solo due. Non potevano bastare. Un po’ più a destra, in un angolo, cuori d’argento su un rosso polveroso. Grappoli luminosi. Aveva allungato una mano, aveva toccato un cuore. Era liscio. E sopra? Ma quel cuore stava bruciando! Andava spento? Era leggero. Come i passerotti che riportava la micia. Con quei becchi gialli e gli occhietti chiusi. Se l’era messo in tasca liscio e leggero e bruciante. Avrebbe funzionato.
ce piccola. E sul muro tante facce e divise e bianco e grigio. Piloti davanti ai loro aerei, piloti in posa, piloti contro lo sfondo del cielo e della pista vuota. Piloti come nonno Enrico, che non aveva mai conosciuto ma che sapeva come il Santo, Santo, Santo. Vorrei portarvi via tutti, aveva pensato. Ma poi si era guardato le mani ed erano solo due. Non potevano bastare. Un po’ più a destra, in un angolo, cuori d’argento su un rosso polveroso. Grappoli luminosi. Aveva allungato una mano, aveva toccato un cuore. Era liscio. E sopra? Ma quel cuore stava bruciando! Andava spento? Era leggero. Come i passerotti che riportava la micia. Con quei becchi gialli e gli occhietti chiusi. Se l’era messo in tasca liscio e leggero e bruciante. Avrebbe funzionato.
E così adesso aspetta che il cuore faccia il suo lavoro. Ha camminato e nel frattempo è scesa la notte e la nebbia si è ingoiata la cima della torre, quella alta, quella da cui se l’aria è pulita si vede il mare. Una strisciolina laggiù. Ma non si deve pensare al mare. Mare vuol dire lei. Vuol dire sale e acqua e qualcosa che non va con lui. In lui. Vuol dire molto caldo e un vuoto che si espande tutt’intorno. Come nello spazio, l’ha visto in un film l’ha visto. Niente mare. Cattivo mare.
La strada è nera e lucida, bava di lumaca – che groppo che gli fanno venire in gola le lumache così nude e morbide e umide. Annusa forte. Sotto i portici c’è già odore d’inverno. Un signore russa piano avvolto in una coperta. È ora di dormire? Tira su il braccio, si scopre il polso sinistro, fa così Don Mauro quando poi dice l’ora. Ma il suo di polso è nudo. Non ha un orologio, ma ha fame. Nella tasca accarezza il cuore, piano, per non spaventarlo. Forza piccolo, lavora. Da un bar si rovesciano fuori delle risate, rumore di bicchieri, voci gonfie che fan paura. E cos’è che batte adesso? Il suo di cuore o quello che brucia? Si piega un poco su se stesso, per ascoltare meglio. Forse è il suo di cuore, quello magico non batte, brucia eterno e basta. Le colonne sfilano alla sua sinistra e gli fanno venire da ridere, dritte così, ma non si ride da soli per strada, sennò si accorgono di te e ti guardano come se dentro portassi nascosto qualcosa di terribile, anche se, che lui sappia, dentro non c’è proprio niente a parte i polmoni e il fegato e il sangue ma quella roba se la portano dietro tutti, no? Allora sta zitto e ride nella sua testa. Imbocca l’ottava strada a destra. Bel numero l’otto, morbido, tondo, bignè alla crema. È da un po’ che segue un odore specifico, odore di legna e cenere, sì, odore di qualcosa che non c’è più. Odore di una casa piccola e un albicocco fuori dalla porta e un gatto con gli occhi azzurri. Non saprebbe ritrovarla quella casa. Sopra la sua testa sfilano persiane chiuse, l’umidità gli si appiccica addosso. Deve aprire bene la bocca per respirare. Non si può fermare. Come gli squali, no? Che non si fermano mai. Non bisogna far spegnere il cuore, sennò non può funzionare. Sennò non può riportarla qui.
Il portone si apre all’improvviso, legno marcio e il freddo che cambia di tono. Stringe il cuore e ci s’infila dentro. Mura gialle canarino uccellino tuorlo d’uovo. Alberi sottili e fuoco e musica, profonda, che gli rimane sotto la suola delle scarpe. C’è uno striscione appeso di traverso sopra le arcate. Non riesce a leggere cosa c’è scritto, linee e curve nere. Gli fanno venire in mente le nuvole che formano gli stormi degli uccelli prima di ripartire per l’inverno. Ce n’erano tante sopra i tetti al mare, il corso vuoto, le cartacce sotto le panchine, le gelaterie chiuse. No, non il mare di nuovo. Scuote la testa Eugenio. Deve tornare qui. Tutt’intorno ci sono le ombre, ombre vicino a un fuoco, ombre sedute a un tavolo sotto stelle di vetro. Ma lui non ha paura, lui ha il cuore, lui è invincibile e presto lei tornerà e riprenderanno da quando l’ha lasciato. Un’ombra si avvicina, gli chiede se ha fame, lui annuisce. Mangia senza guardare nel piatto, fissa le fiamme e inspira il fumo. Mangia in piedi dondolandosi piano. Non ci si ferma. No, non ci si ferma. La nebbia sta scendendo ancora. Deve andare. S’inchina alle ombre e poi s’incammina, curvo su se stesso, una conchiglia intorno alla speranza.
Buio e umido intorno e dentro un frullio sommesso. Prega i suoi piedi di continuare a disegnare la mappa per tornare da lei, ma c’è un peso nuovo nelle ossa, un chiarore inizia a diffondersi su nel cielo.
All’improvviso tutto esplode di giallo. A terra, in aria. Il giallo scende in piccoli riquadri e tappezza la piazza. Come carte di caramelle, come miele quando aveva il mal di gola. Le sue dita trovano le fiamme del cuore. Vorrebbe che gli tagliassero via la pelle. Anche se sa che pure questo non va bene, che anche questo fa piangere l’uomo sulla croce. Si abbassa, infila le mani tra le foglie, sono sottili. Ventagli piccoli che sanno di terra. Un tempo gli hanno detto come si chiamava l’albero da cui son cadute ma lui il nome non lo ricorda. Sono ovunque, i ventagli, fino al portale della chiesa. È enorme e gli fa tremare i polsi.
Perché ancora lei non è qui? Perché non arriva ad abbracciarlo, a cancellare le parole e le medicine e gli sguardi.
Eppure lui ha camminato, ha cullato il cuore amuleto magia e adesso la notte sta per finire. Afferra il cuore lo tira fuori dal suo nascondiglio nero naftalina. Se lo rigira tra le mani. Brutto cuore. Cattivo cuore.
Lo schianta a terra in mezzo al giallo. E da dentro, in fondo al sangue e alle cose più nascoste, nasce un urlo che gli risale su per la gola ed esce nel mondo.
Nella testa è un rollio di suoni e il mare e il vento. Ha disegnato una mappa per lei, ci ha messo il cuore in mezzo. E tanto lei non torna. Lei con la sua mano grande intorno alla sua piccola. Già sbagliata. Per sempre sbagliata.
Cristiano Baricelli nasce a Genova nel 1977. Autodidatta dal 1997, elabora una personale tecnica di disegno basata sull’uso della penna a sfera. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali e collabora con Fanzine e Magazine di illustrazione tra cui: Grrrz Comic Art Books, Nurant, Osel,Watt, CartaCanta, Nitch, L’inquieto, Pastiche, Verde Rivista, Antropoide, Illustrati, Nèura, Freak Out, Guida 42, Carie, Rituali, Effe Rivista, Risme, Squadernauti, Racconti Crestati, Digressioni, Horror Moth. Attualmente sta sperimentando tecniche miste, e odia svegliarsi presto la mattina.
 Sara, Brando, Larcher e Michele hanno tredici anni nel Natale del 1996, funestato da due morti che sconvolgono la comunità e sollevano sospetti. Alla loro età i gravami e i crucci della condizione umana li raggiungono solo di riflesso, quando gli adulti non sono capaci di proteggerne l’innocenza tenendoli per sé. Non possono immaginare che gli eventi di quelle ore finiranno per annodare indissolubilmente le loro vite e segnare per sempre quelle dei genitori, del giovane parroco, don Maurizio, e persino del povero Gianin, il matto dal braccio sifulo che vive in una catapecchia comunale con la sua cagnetta Mimì. Un’ombra nera, spessa e opprimente calerà sull’intero paese, sovrapponendosi alla nebbia che già ammanta le strade e offusca i pensieri, quando non è sufficiente il vino che l’Anna serve nel suo storico bar a pochi passi dalla chiesa.
Sara, Brando, Larcher e Michele hanno tredici anni nel Natale del 1996, funestato da due morti che sconvolgono la comunità e sollevano sospetti. Alla loro età i gravami e i crucci della condizione umana li raggiungono solo di riflesso, quando gli adulti non sono capaci di proteggerne l’innocenza tenendoli per sé. Non possono immaginare che gli eventi di quelle ore finiranno per annodare indissolubilmente le loro vite e segnare per sempre quelle dei genitori, del giovane parroco, don Maurizio, e persino del povero Gianin, il matto dal braccio sifulo che vive in una catapecchia comunale con la sua cagnetta Mimì. Un’ombra nera, spessa e opprimente calerà sull’intero paese, sovrapponendosi alla nebbia che già ammanta le strade e offusca i pensieri, quando non è sufficiente il vino che l’Anna serve nel suo storico bar a pochi passi dalla chiesa.