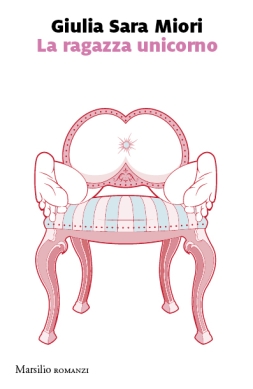 E già dall’incipit, attraverso una voce narrante caratterizzata con efficacia da una paratassi fluida e asciutta, veniamo a sapere quale sia il momento esatto in cui tutto ha inizio: “L’avevano prelevato il giorno del suo compleanno: il 27 gennaio 2022, alle 18.41. Era un giovedì e aveva appena finito di lavorare” (p. 13). Due sconosciuti si avvicinano al protagonista all’uscita dall’ufficio e spacciandosi per poliziotti lo convincono a salire sulla loro auto. Verrà bendato e condotto nel luogo della sua prigionia.
E già dall’incipit, attraverso una voce narrante caratterizzata con efficacia da una paratassi fluida e asciutta, veniamo a sapere quale sia il momento esatto in cui tutto ha inizio: “L’avevano prelevato il giorno del suo compleanno: il 27 gennaio 2022, alle 18.41. Era un giovedì e aveva appena finito di lavorare” (p. 13). Due sconosciuti si avvicinano al protagonista all’uscita dall’ufficio e spacciandosi per poliziotti lo convincono a salire sulla loro auto. Verrà bendato e condotto nel luogo della sua prigionia.
“La cella misurava due metri per tre. Era senza finestre. Completamente bianca: bianche le pareti, bianco il pavimento, bianca la luce che si diffondeva dalla lampadina sul soffitto. […] Il prigioniero abbassò lo sguardo sul proprio corpo. Indossava un’uniforme bianca, un paio di ciabatte bianche, un paio di calzini bianchi. Tirò l’elastico dei pantaloni per dare un’occhiata alle mutande. Non si stupì quando notò che erano bianche, senza scritte né etichette” (p. 28).
Il bianco ovunque, come simbolo dell’innocenza che il prigioniero professa a se stesso e ai propri carcerieri, il pelato e l’uomo coi baffi: “Sono una persona perbene, si disse a voce alta mentre d’istinto si voltava verso la finestra, che però non c’era. Non ho mai fatto del male a nessuno” (p. 52). Ma nell’atto di essere spogliato e privato del colore, c’è anche l’allusione al processo di espiazione e catarsi cui si appresta ad andare incontro, durante le infinite attese tra un interrogatorio e l’altro, nel silenzio e in una luce perenne che annullano lo scorrere del tempo, rimescolando il giorno e la notte in un presente indistinto fatto di domande, congetture, paura e certezze che poco alla volta si sgretolano. Perché la verità che il prigioniero ricorda e racconta non coincide con quella mostrata dalle prove in mano ai suoi misteriosi inquisitori.
E proprio stabilire la verità, non perseguire la giustizia o formulare un giudizio morale, pare essere il fine di quanto sta accadendo. Eccolo, allora, il rumore, flebile, quasi impercettibile eppure impossibile da ignorare. “Però non si trattava esattamente di un rumore. Era più un fruscio, come di foglie che si agitavano al vento. Forse sono le piume di un uccello, si disse, ma subito dopo si rese conto dell’assurdità di quel pensiero” (p. 71). “Era come se qualcuno, forse una donna, facesse strisciare per terra il lungo velo di un abito da sposa” (p. 80). Richiamando il battito del cuore rivelatore nel racconto di Edgar Allan Poe, quel non-rumore scandisce la discesa del protagonista tra le nebbie dell’indicibile, non in cerca di assoluzione, perché persino lui ormai dubita di sé, e nemmeno della libertà perduta, bensì in fuga da quello stesso silenzio che non è più in grado di sostenere.
Ma se la verità umana è materia malleabile, quanto è disposto a sacrificare il prigioniero, prima di rinnegare quella che ha plasmato a misura della propria coscienza?
(Gianni Usai)



