E si conclude anche la carriera letteraria di Don Winslow, che ha scelto di dedicarsi all’attivismo politico (o più precisamente, come egli stesso ha dichiarato in svariate occasioni, a una strenua campagna denigratoria nei confronti di Donald Trump).
Città in rovine ci mostra un Danny Ryan maturo, che si è lasciato alle spalle gli anni della guerra per il controllo del New England tra la fazione irlandese (che ha finito per capeggiare) e quella italiana.
Ora Ryan abita a Las Vegas, è un ricco uomo di affari, socio occulto di due hotel di lusso. Ma è inquieto. Perché “il concetto di ‘abbastanza’ non esiste a Las Vegas, una città esagerata dove il troppo non è abbastanza, il successo è l’eccesso e il di più è sempre meglio.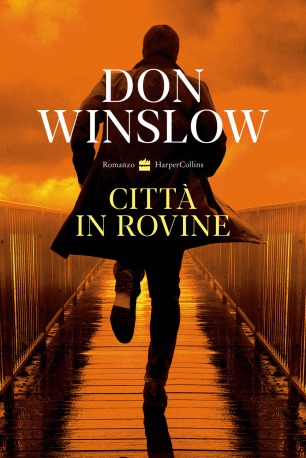
Hai un regno, aveva pensato Danny, ma vuoi un impero” (p. 71).
E così, Danny Ryan brama di trasformare un hotel in un enorme resort, sottraendolo al gruppo imprenditoriale rivale che sta per concluderne l’acquisto. Per riuscire nell’intento, tuttavia, dovrà permettere al proprio passato di riaffiorare. Ma siccome si tratta di un passato di malaffare, la prima mossa in quella direzione ne scatenerà inevitabilmente altre, che lo trascineranno in una nuova e sempre più sanguinosa battaglia.
Nella sua ultima opera, Winslow dimostra ancora una volta di saper maneggiare con grande disinvoltura tutti gli strumenti necessari a confezionare un noir impeccabile: la trama è solida e ricca di colpi di scena; atmosfere e toni da tragedia e commedia si alternano con sapienza; i personaggi sono vividi, umanissimi nei loro dilemmi morali e allo stesso tempo emblematici. Spicca poi una profonda conoscenza dei vari ambiti trattati nelle oltre quattrocentocinquanta pagine del volume, da quello legislativo a quello finanziario, per prendere solo due esempi.
Ma c’è, soprattutto, la conferma che Don Winslow ha saputo elevare il noir da cosiddetta narrativa di genere a epica contemporanea. Nelle atmosfere shakespeariane dei suoi poderosi romanzi l’amore, l’odio, la fedeltà, il tradimento, il potere e il denaro muovono, miscelandosi tra loro in percentuali differenti, tutte le azioni.
In Città in rovine poi, scritto e probabilmente pensato come opera di addio, signoreggia qualunque gesto e progetto, anche il più ambizioso, un forte senso di precarietà. In fondo, a rivedere retrospettivamente questa trilogia e l’intero corpus di Winslow, ogni personaggio – come nella favola della rana e dello scorpione – ha semplicemente prestato fedeltà alla propria natura. E ha fornito il proprio personale contributo alla vanità del disegno complessivo: “Danny Ryan osserva il crollo dell’edificio. […]
Guarda salire la polvere, una nuvola a fungo color marrone grigiastro contro il cielo azzurro e sereno del deserto.
Lentamente sbiadisce e poi scompare.
Ora non c’è più nulla.
Ho combattuto, pensa. Ho dato tanto per questo…
Nulla.
Per questa polvere” (pp. 438-9).
(Claudio Bagnasco)



