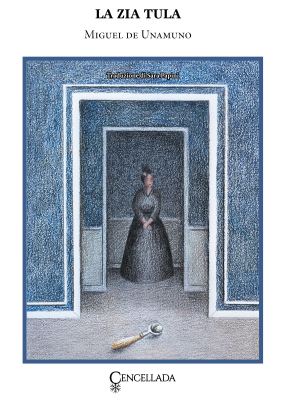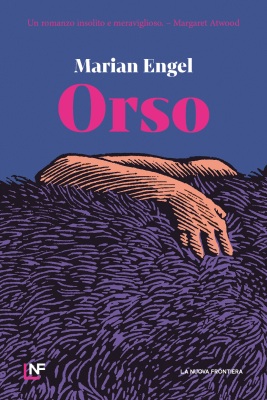 Orso di Marian Engel (La Nuova Frontiera, 2024, traduzione di Veronica Raimo), considerato un classico della narrativa erotica, racconta la passione di una donna nei confronti di un orso senza cadere nel ridicolo o nella trivialità, anzi rendendo la vicenda a suo modo quasi plausibile. Lo sviluppo di una passione così inusuale è descritto in tutti i passaggi: il primo incontro la sera dell’arrivo di Lou nella grande casa del Colonnello Cary; il primo contatto, quando l’orso lecca a Lou la mano; l’occasione in cui i due fanno i bisogni fianco a fianco, confidenza che a quanto pare suscita un vero piacere nella bestia; i quotidiani bagni nel fiume, non appena la stagione lo permette; l’ammissione dell’animale in casa, vinta la paura di condividere uno spazio confinato con un animale le cui dimensioni, al chiuso, appaiono ancora più imponenti; la scoperta del piacere di immergere le mani nella folta pelliccia; la caduta di timori e tabù e la conseguente conquista dell’intimità.
Orso di Marian Engel (La Nuova Frontiera, 2024, traduzione di Veronica Raimo), considerato un classico della narrativa erotica, racconta la passione di una donna nei confronti di un orso senza cadere nel ridicolo o nella trivialità, anzi rendendo la vicenda a suo modo quasi plausibile. Lo sviluppo di una passione così inusuale è descritto in tutti i passaggi: il primo incontro la sera dell’arrivo di Lou nella grande casa del Colonnello Cary; il primo contatto, quando l’orso lecca a Lou la mano; l’occasione in cui i due fanno i bisogni fianco a fianco, confidenza che a quanto pare suscita un vero piacere nella bestia; i quotidiani bagni nel fiume, non appena la stagione lo permette; l’ammissione dell’animale in casa, vinta la paura di condividere uno spazio confinato con un animale le cui dimensioni, al chiuso, appaiono ancora più imponenti; la scoperta del piacere di immergere le mani nella folta pelliccia; la caduta di timori e tabù e la conseguente conquista dell’intimità.“Ora sapeva di amarlo. Lo amava in modo così esorbitante che il resto del mondo si era ridotto a un inutile groviglio senza senso, a parte il paesaggio, che esisteva al di là di loro: neutrale, con i suoi personali orgasmi estivi” (p. 106).
Difficile ridurre i due personaggi a schemi preconfezionati: la grigia archivista Lou, oltre a destreggiarsi in un ambiente selvaggio affrontato in completa solitudine, dà prova di una vita sessuale abbastanza disordinata: in città aveva rapporti settimanali con il Direttore della biblioteca, ma si scopre come avesse anche abbordato uno sconosciuto per strada. Prima ancora ebbe un amante descritto come elegante e fascinoso, sebbene poco passionale. La vediamo infine affascinare senza intenzione Homer, l’unico altro umano che compare nel romanzo, e copulare con lui per saziare il desiderio generato dall’orso . Niente a che vedere con lo stereotipo della zitella.
Parimenti, l’orso non è riconducibile a una particolare categoria: non rappresenta la natura selvaggia, in quanto vecchio e abituato alla catena che lo lega alla cuccia, ma non può nemmeno dirsi del tutto addomesticato. Pur non dimostrando alcuna aggressività, la sua mole, i denti e le unghie rappresentano un pericolo. E nonostante diventi l’oggetto del godimento di Lou, non pare essere attratto sessualmente dalla donna, se non per gli odori che il suo corpo emana e che la bestia annusa o lecca come farebbe con qualsiasi altra essenza o liquido. È questo il suo modo di entrare in contatto col mondo ha detto Lucy Leroy, nativa americana centenaria che già si prendeva cura dell’orso quando ancora il colonnello era in vita. Eppure quell’abitudine al corpo femminile appare sospetta: ci si immagina sia stata Lucy ad ammaestrarlo ai giochi erotici, oppure la stessa Colonnello Jocelyn Cary – ebbene sì, una donna, non un uomo.
Le due creature non paiono comprendersi fino in fondo, sembrano piuttosto accompagnarsi, e godersi la libertà dalla catena – materiale per l’orso, sociale per Lou – che ciascuna concede all’altra. Lei alla fine dell’estate tornerà in città, decisa a cambiare lavoro, forse vita. L’orso viene preso in carico da Joe King, nipote di Lucy. “Sarà felice di rivederlo” rivela Joe a Lou, parlando di Lucy. “Non si può negare che sia ossessionata da quell’orso. Dice che non ha nessuno con cui parlare. Spera che voi due siate diventati amici”. “Siamo andati a nuotare insieme” (p. 123) risponde Lou, sorniona.
(Giovanni Locatelli)